La Madonna della Consolazione: un simbolo eterno per Reggio Calabria. Ecco come la Madre visita i suoi figli amatissimi ogni anno
Indice articolo
A Reggio Calabria, la fede ha un volto. Non è un concetto astratto, né una parola da ripetere nelle omelie. È un volto che consola, un volto che ascolta. È quello della Madonna della Consolazione, la “Mamma” della città, la Santa Patrona, la Signora vestita d’oro che da secoli veglia sulle case, sui mari inquieti, sulle vite stanche e sulle gioie improvvise di chi abita questo lembo di terra affacciato sullo Stretto. Solo un altro modo per chiamare la Madonna. Qui, la devozione non è mai stata una questione privata. È sangue che scorre nelle vene della città, è memoria collettiva, rito condiviso. La Madonna della Consolazione non è solo un’immagine sacra: è una presenza reale, che scende tra le strade, che si lascia toccare, al passaggio della quale si può piangere, gridare, solo per poi accorgersi che una dolce benedizione è discesa a placare ogni inquietudine. È la madre che non giudica, che non dimentica. La città le parla, canta lodi in suo nome, la porta sulle spalle. E ogni anno, questo patto d’amore si rinnova. Con lo stesso fervore, con la stessa emozione che tremava negli occhi dei bisnonni.

Titoli Mariani: cosa sono e quanti sono tutti i nomi dedicati a Maria
Titoli Mariani: tutti gli appellativi con cui viene venerata Maria…
Le feste dedicate ai Santi nel Sud Italia sono un vero patrimonio di storia, folklore e arte. Fuochi d’artificio sul mare, processioni che attraversano borghi e campagne, tavole imbandite di piatti tipici e antiche preghiere sussurrate sotto il cielo d’estate. Le feste patronali sono molto più che celebrazioni religiose: sono momenti di identità collettiva, in cui fede, folklore e convivialità si intrecciano in un rito che attraversa i secoli. Così è anche per la festa della Madonna della Consolazione.

Le 5 feste dei santi più famose nel sud Italia
Tra processioni tra terra e mare, fuochi d’artificio e specialità gastronomiche, scopriamo le feste dei santi…
Quando si festeggia la Madonna della Consolazione?
C’è un luogo, a Reggio Calabria, dove il cielo sembra più vicino. Dove l’aria profuma di silenzio, e ogni passo risuona come una preghiera. È lì, sulla collina che domina la città e il mare, che sorge la Basilica dell’Eremo, dimora della Madonna della Consolazione per la maggior parte dell’anno.
Non è solo una chiesa. È il cuore nascosto della devozione reggina, un santuario che custodisce l’attesa, la speranza, la promessa. Fu costruita accanto al convento dei frati Cappuccini, che arrivarono in città nel 1532 portando con sé la semplicità e la forza del messaggio francescano. In quel tempo, dove ora s’innalza la Basilica, sorgeva una piccola cappella. Poi venne il quadro, commissionato dal nobile Camillo Diano al pittore reggino Nicolò Andrea Capriolo. E la devozione prese forma, volto, colore.
La prima chiesa resistette per secoli, ma il terremoto del 1908 la piegò. Non lo spirito, però. E così, nel 1965, sorse una nuova Basilica. Moderna nelle linee, ma antica nell’anima. Progettata dall’architetto Anna Sbarracani Anastasi, accoglie oggi non solo la sacra effigie, ma anche opere d’arte che parlano con la voce della contemporaneità: i rilievi di Alessandro Monteleone, la Via Crucis scolpita da Pasquale Panetta, i vetri colorati che rifrangono la luce come promesse.

Padre Pio e l’ordine dei Frati Minori Cappuccini
Padre Pio dimostrò fin da giovane il desiderio di abbracciare la vita religiosa: entrò in convento a quattordici…
Quando, a settembre, la Madonna scende in città, l’Eremo si svuota di presenza, ma non di significato. E in novembre, quando torna tra le sue mura, tutto ricomincia. I gradini della scalinata diventano rosario, la salita si fa preghiera in cammino. È lì, nel silenzio dell’altura, che i reggini tornano a cercarla nei mesi che separano una festa dall’altra. Una visita, una candela, una lacrima. Nessuno va via senza averle parlato.
La Basilica dell’Eremo è il luogo dove la Madre riposa. Ma lassù, lo sappiamo bene, non dorme mai.
Settembre a Reggio ha il profumo del mirto e della cera. Ma soprattutto, lungo le sue strade risuona il passo cadenzato dei portatori della Vara, il brusio dei fedeli, le campane che annunciano l’atteso giorno della Discesa.
Accade ogni anno, il secondo sabato di settembre. All’alba, mentre la città si stiracchia nel sonno, già si sente il mormorio salire dalla collina dell’Eremo. Gente che arriva a piedi nudi, per devozione. Gente che non ha dormito, per l’emozione. Sono migliaia, ogni anno, come un fiume che ha imparato a scorrere sempre verso la stessa sorgente.
Il quadro sacro lascia la sua dimora per scendere tra il popolo. Non è solo una processione: è un incontro. È la storia che si fa carne, ogni volta. Si racconta che tutto iniziò nel 1636, durante una terribile pestilenza. Il popolo fece voto: “Porteremo la Madonna in città, se ci libererà dalla peste.” E così fu. Da allora, settembre è il mese del grazie. Il mese del miracolo che si rinnova.

C’è un momento, nell’interminabile abbraccio tra la città e la sua Patrona, in cui la devozione diventa corsa. È la Volata, l’ultimo tratto della processione, quando i portatori, stremati, sudati, ma col cuore in fiamme, stringono i denti e, sotto il peso della Vara, affrontano di corsa lo spazio che separa l’inizio di Piazza Duomo dalla scalinata della Cattedrale.
È un gesto che sfida la ragione, ma che parla alla parte più profonda dell’anima. Perché la Volata non è solo una corsa: è un’offerta. È l’atto finale, l’ultimo dono alla Madonna. È la dimostrazione estrema di un amore che non si risparmia, che si consuma fino all’ultima goccia di energia. E quando la Vara arriva, tra gli applausi e le lacrime, il respiro di tutti sembra trattenersi per un istante. È fatta. La Madre è tornata.
Ma la festa non si conclude lì. Il martedì successivo, come a voler prolungare l’incanto, la Madonna percorre ancora una volta il Corso Garibaldi, tra ali di folla che si stringono per salutarla. È un arrivederci più lieve, più intimo. Poi il quadro rientra nella Cattedrale, dove rimarrà fino al mese di novembre, tra luci, fiori, e una città che si stringe attorno a lei come un figlio al grembo della madre.
A novembre arriva un altro momento solenne: la festa della Presentazione di Maria al Tempio. È allora che la Madonna prepara il ritorno all’Eremo. Ed è allora, con la processione della Salita, che la Madre fa ritorno alla Basilica dell’Eremo. Così si chiude il cerchio. Così si rinnova, ogni anno, quel misterioso dialogo tra cielo e terra che lega Reggio alla sua Consolatrice. Un ciclo d’amore che non conosce fine. Ma quella, si sa, è un’altra storia. Un’altra emozione.

La Festa della Madonna della Salute di Venezia
Ogni anno, il 21 novembre, i veneziani si riuniscono per onorare la Madonna della Salute, un evento…
Quando sale la Madonna della Consolazione all’eremo?
Se la Discesa è festa, la Salita è preghiera. È più intima, più silenziosa, eppure non meno intensa. Succede la domenica dopo il 21 novembre, come un addio sussurrato sotto voce, tra la malinconia dell’autunno e la speranza che accompagna ogni ritorno.
La processione parte lenta, quasi timida. La città, che solo due mesi prima l’aveva accolta con grida e applausi, ora saluta la sua patrona con occhi lucidi e mani giunte. È un congedo che pesa sul cuore. Ma è nel tratto finale che tutto cambia. La strada si inerpica verso l’alto, e con essa la Vara, i portatori, i canti che si spezzano in gola. Ogni passo diventa un atto di fede, ogni respiro un’offerta. Nessuno parla, ma tutti sentono la stessa cosa: che quell’ascesa appartiene a tutti loro. Che ciascuno tra i presenti, come la Madonna, ogni giorno affronta una salita impervia. Una fatica, un dolore, una rinascita.
All’arrivo all’Eremo, il tempo sembra fermarsi. L’aria profuma d’incenso e foglie bagnate. Il quadro viene accolto dai frati, ricollocato sull’altare maggiore. E i fedeli, molti con le lacrime agli occhi, restano lì, in silenzio. Perché dire addio alla Mamma, anche se solo per qualche mese, non è mai facile.
Ma da lassù, sulla collina, la Consolatrice continuerà a guardare verso il mare. E verso tutti i suoi figli amatissimi.

Quanto pesa la Vara della Madonna della Consolazione?
Chi non l’ha mai vista, forse non può immaginare. La Vara non è solo una struttura. È un tempio che cammina. Un altare in movimento. Un monumento alla fede collettiva. Realizzata tra il 1824 e il 1831, la monumentale Vara è un capolavoro di arte devozionale: lamina d’argento sbalzato su un’anima di legno, scolpita e cesellata con minuzia, come si addice a ciò che deve contenere il sacro. Alta circa cinque metri e decorata con dettagli che raccontano la gloria e il dolore, raggiunge un peso complessivo di 1.400 chilogrammi. Una tonnellata e mezza che non spaventa, ma onora. Sì, una tonnellata e mezza di bellezza e devozione.
Per portarla, servono almeno sessanta uomini. Portatori della Vara, li chiamano. Ma chi conosce la tradizione sa che sono molto di più. Sono devoti, figli, fratelli, padri. Per molti, è un’eredità: “Mio nonno la portava. Mio padre la portava. Ora tocca a me.”
Durante la processione, si danno il cambio con gesti studiati, quasi coreografici, ma carichi di rispetto. Ogni sostituzione è un rituale. E quando arriva il tratto della salita all’Eremo, la fatica si fa eroica. Le gambe tremano, le mani stringono forte le stanghe, e la città intera trattiene il fiato.
Ma nessuno si tira indietro. Perché quel peso, in fondo, è il peso dell’amore. E l’amore, si sa, non pesa mai abbastanza.

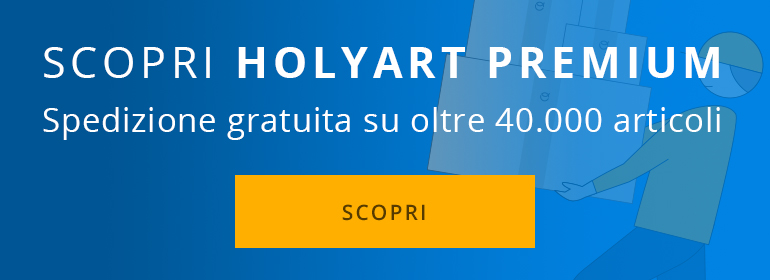














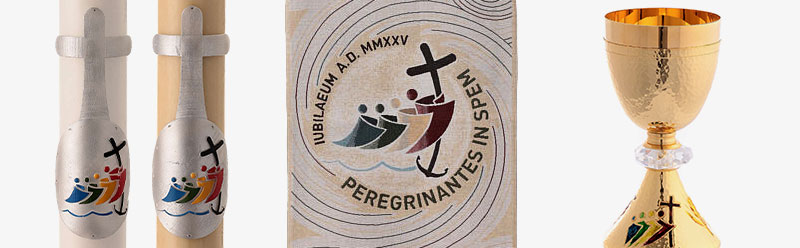




 22 Dicembre 2025
22 Dicembre 2025


