La differenza tra ateo e agnostico si basa principalmente sulla posizione che ciascuno assume riguardo all’esistenza di Dio e della trascendenza
Indice articolo
Spesso si parla di ateismo e agnosticismo senza comprendere appieno la differenza tra ateo e agnostico. Una differenza sottile, da ogni punto di vista la si voglia analizzare, ma fondamentale. Essa non abbraccia unicamente la sfera religiosa, ma tutto ciò che si rapporta a una realtà trascendente. In un’epoca in continua e frenetica evoluzione, nella quale diventa sempre più difficile credere veramente in qualcosa, e, nello stesso tempo, è troppo facile abbandonarsi a convinzioni fallaci, falsi idoli e illusioni destinate a infrangersi fin troppo dolorosamente, parlare della fede, o della mancanza di fede, diventa emblematico e purtroppo attuale. Esaminiamo le principali differenze tra ateismo e agnosticismo e cerchiamo di fare chiarezza su queste due posizioni.
L’ateismo è posizione di decisa negazione. Negazione dell’esistenza di Dio e di qualsiasi trascendenza divina. L’ateo è colui che afferma con sicurezza che Dio non esiste. Per supportare la propria affermazione può invocare la mancanza di prove o motivazioni sufficienti. In questo senso possiamo distinguere gli atei attivi (o forti), che non si fermano alla semplice assenza di credenza, ma esprimono una dichiarazione attiva e convinta contro l’esistenza di divinità, dagli atei passivi (o deboli), ovvero coloro i quali si astengono dal credere sul principio che non ci sono prove scientifiche o empiriche che dimostrino l’esistenza di Dio, e quindi non c’è ragione di credere in ciò che non è dimostrabile. In pratica l’ateo forte afferma con decisione: “So che Dio non esiste”, mentre l’ateo debole si limita a dire: “Non ho ragioni o prove sufficienti per credere in Dio”.

Quali sono i nomi di Dio
I nomi di Dio non sono solo modi di rivolgersi a Lui e di venerarlo, ma espressioni della Sua essenza e un tentativo…
In un certo senso gli agnostici sono vicini alla posizione degli atei deboli, in quanto l’agnosticismo sospende il giudizio sull’esistenza di Dio o su qualsiasi realtà trascendente per l’impossibilità di conoscerne o dimostrarne con certezza l’esistenza o l’inesistenza. L’agnosticismo non nega Dio o la trascendenza divina, si limita a dichiarare che la conoscenza di queste questioni è al di là della portata umana. Thomas Henry Huxley, il biologo che coniò il termine agnosticismo, ha riassunto molto bene questa posizione nell’affermazione: “Un uomo non deve dire di conoscere o credere ciò di cui non ha motivi scientifici per professare di conoscere o credere.”
In questo senso l’agnosticismo incarna un atteggiamento di umiltà intellettuale di fronte ai grandi misteri dell’esistenza. Per certi versi può essere considerato una reazione uguale e contraria alla fede: l’uomo di fede crede senza interrogarsi su chi e cosa potrebbe dimostrare l’esistenza di Dio, mentre l’agnostico non può affidarsi alla fede, in quanto essa non ha fondamento scientifico ed empirico.
Nell’epoca contemporanea, in un contesto di crescente secolarizzazione e individualizzazione del rapporto non solo col divino, ma in generale con la spiritualità, perfino con la filosofia, la differenza tra ateo e agnostico diventa emblematica e applicabile in molte circostanze, che esulano dalle convinzioni religiose. Altri atteggiamenti nei confronti di Dio sono il Teismo, la convinzione che Dio esista come essere personale, creatore e amante della sua creazione, come nel Cristianesimo, secondo il quale Dio si rivela per salvare l’uomo, arrivando a incarnarsi e sacrificarsi per lui; il Deismo, che sostiene l’esistenza di un Dio creatore, ma distante e disinteressato alla sua opera; il Panteismo, secondo cui il divino è impersonale e coincide con la realtà stessa, che ne sarebbe un’emanazione, per cui tutto è Dio e Dio è in tutto. Questo pensiero è tipico delle religioni orientali come Induismo, Buddismo e Taoismo.

Le maggiori divisioni nella religione cristiana
La religione cristiana è in realtà formata da molte confessioni religiose, simili per alcuni aspetti…
Credere in Dio, ma non nella chiesa
Molte persone oggi si identificano come credenti “non praticanti” o “spirituali, ma non religiosi”. Questa posizione riflette una fede personale in un’entità superiore, che tuttavia rifiuta l’intermediazione delle istituzioni religiose organizzate. Le motivazioni di chi porta avanti questa posizione vanno da una critica più o meno esplicita alla gestione del potere religioso, al disaccordo con le interpretazioni dogmatiche e al conseguente rifiuto dei rituali e delle pratiche religiose istituzionalizzate, ma si basano anche più semplicemente su una preferenza personale per un rapporto diretto e intimo con Dio, senza bisogno di intermediari umani.
Qual è il significato di agnosticismo?
Il termine “agnostico”, coniato da Thomas Henry Huxley nel 1869, deriva dal greco antico ἀ- (a-, “senza”) e γνῶσις (gnōsis, “conoscenza”). L’agnosticismo ha radici antiche. Già Protagora e gli esponenti dello scetticismo greco sostenevano che tutta la conoscenza umana è imperfetta e dubitabile. Anche Democrito, fondatore dell’atomismo, è stato talvolta visto come un pensatore vicino all’ateismo, in quanto tendeva a spiegare i fenomeni naturali, compresi quelli che venivano attribuiti agli dèi, attraverso cause puramente materiali, senza fare ricorso a spiegazioni divine. Le sue teorie cercavano di sostituire il mito e la religione con una visione razionale e scientifica del cosmo. In realtà Democrito non negò esplicitamente l’esistenza degli dèi, ma li considerava probabilmente come concetti creati dall’uomo.
Questa posizione venne osteggiata a lungo nella cultura occidentale. Sant’Agostino d’Ippona, uno dei più famosi Padri della Chiesa, si oppose strenuamente alle posizioni scettiche e agnostiche, in particolare quella dei filosofi della scuola platonica tardiva che ritenevano che “alla natura umana è negata la conoscenza”. Agostino credeva che la ragione umana, pur limitata, potesse essere guidata dalla fede verso una comprensione autentica delle verità divine. La fede era un mezzo per raggiungere la conoscenza e l’amore per Dio portava alla vera comprensione della realtà.

Le confessioni di sant’Agostino: come cambiare la propria vita
Le Confessioni di Sant’Agostino sono la testimonianza di un cammino di fede e di presa di coscienza…
Nell’epoca moderna, filosofi come Immanuel Kant ribadirono l’idea che la ragione umana non può né confermare né negare l’esistenza del noumeno, ovvero l’incondizionato. L’agnosticismo è diventato così una posizione intellettuale che si colloca tra la fede e l’ateismo. Ludwig Feuerbach, fondatore dell’ateismo ottocentesco, sostenne che l’uomo ha creato Dio proiettando su di Lui qualità umane e che l’ateismo è un dovere morale perché l’uomo deve recuperare in sé le virtù attribuite a Dio. Karl Marx, pur correggendo Feuerbach, vede nella religione l’“oppio dei popoli”, un mezzo per compensare nell’aldilà le ingiustizie e i desideri irrealizzati della vita terrena, generati da una società iniqua.

I padri della Chiesa: chi erano e cosa si intende per patristica
I Padri della Chiesa sono i principali scrittori cristiani, le opere dei quali costituiscono le basi della dottrina…
Cosa vuol dire agnosticismo metafisico?
L’agnosticismo metafisico rappresenta una forma più profonda di agnosticismo che si estende oltre la questione religiosa. Questa prospettiva filosofica sostiene che la realtà ultima dell’universo è fondamentalmente inconoscibile e che i limiti della conoscenza umana impediscono la comprensione delle verità metafisiche. Come riguardo la possibilità o meno di affermare l’esistenza di Dio, per chi si identifica nell’agnosticismo metafisico anche le questioni fondamentali sull’esistenza, la coscienza e il significato ultimo della vita rimangono irrisolvibili.
Tanto l’agnosticismo religioso, che si concentra specificamente sulla questione dell’esistenza di Dio, quanto quello metafisico, condividono un approccio razionale e scettico alla conoscenza, il riconoscimento dei limiti della comprensione umana e, di conseguenza, la sospensione del giudizio su questioni non empiricamente verificabili.

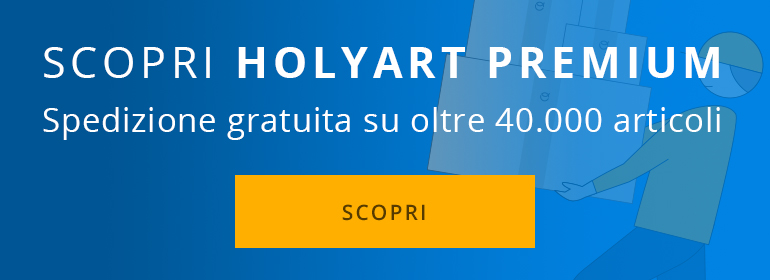

















 9 Febbraio 2026
9 Febbraio 2026


